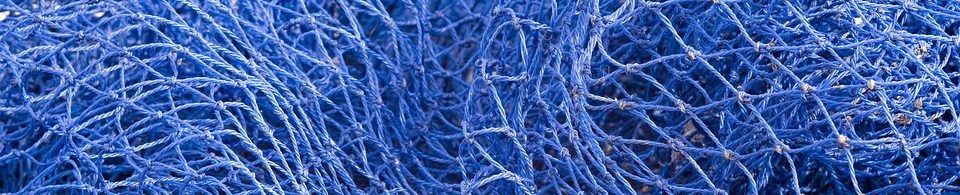CARTA PENNA E CALAMAIO. Carta, penna, calamaio… e matita di P. P. Roe (Pietro Paolo Capriolo)
La prendo in mano quando desidero scrivere qualcosa di più impegnativo d’un semplice appunto o richiamo mnemonico su foglietto. È la mia fedele matita a pulsante, di quelle con un serbatoio di ricarica abbastanza ampio per accogliere almeno quattro o cinque mine di grafite calibro 0,5 millimetri: praticamente sempre appuntita. L’impugnatura antiscivolo è per qualcuno cicciotta, ma perfetta per me che ho le ossa lunghe anche nelle falangi delle mani e così non la devo stringere troppo, ma quasi soltanto trattenere fra pollice e indice nel balletto sulla carta. Le penne a sfera, pur di dimensioni accettabili, hanno la prerogativa difettosa di dover essere tenute in verticale per permettere all’inchiostro gelatinoso di uscire regolarmente dall’ugello. Quanti bambini ed altresì altrettanti adulti, compagni d’università e colleghi di lavoro, ho visto (e bonariamente redarguito, senza successo) inclinare il capo per poter seguire i propri grafismi, affaticando inevitabilmente un occhio più dell’altro, data la minor distanza dal foglio!
Chi è stato sui banchi di scuola con il piano inclinato ed il foro in alto a destra dov’era conficcato il calamaio, ricorderà certamente che, passato il tempo del primo apprendimento della scrittura a matita, un giorno la maestra ci traghettò dall’era della grafite a quella dell’inchiostro. Nero ce lo versò il bidello da una caffettiera stile Far West in quel contenitore di vetro o ceramica: appena un dito sul fondo, perché ancora non sapevamo intingere la penna e successivamente sgocciolare sul bordo l’eccesso di quel liquido dall’odore ferrigno e rugginoso. Quale emozione estrarre finalmente dal portapenne l’asticciola a cannula affusolata ed infilarvi il pennino nell’estremità contenente un rudimentale fermaglio di acciaio per trattenerlo!
C’erano (ed ancor ci sono) pennini di tante forme dai nomi difficilissimi (Mitchell, Brause, Speedball) studiati apposta per i bravi scritturali di uffici pubblici e privati e per i calligrafi che sapevano vergare le pergamene ed i diplomi con gli svolazzi. A noi bambini il cartolaio proponeva economici pennini dal colore bronzeo con la forma che richiamava il dorso d’un improbabile coleottero metallico con le elitre divise solamente sull’estremità: li estraeva da una scatola con la scritta Perry & Co. e questo era il tipo più diffuso nelle scuole, ma qualcuno sfoggiava anche il più costoso Perry Superior (da noi detto semplicemente London) dal colore quasi argenteo che aveva non un semplice foro sopra il taglio, ma due aperture: una a V e un’altra a forma di croce greca. Non ho mai appurato se fosse per necessità o per rito scaramantico che qualcuno lo facesse transitare qualche secondo sulla fiamma al suo primo uso. Quello a forma di Tour Eiffel (ma per noi era la Mole Antonelliana) era leggermente più caro del normale Perry, tratteneva meno inchiostro e bisognava quindi intingerlo più sovente, ma soprattutto si deformava facilmente sotto una mano pesante e nelle inevitabili cadute a terra della penna. Generazioni di alunni prima di noi avevano lasciato in eredità nel bordo verso lo scrivano una serie di forellini anneriti e l’esperienza tramandata ci aveva insegnato ad approfittarne per raddrizzare la punta dei pennini vittime di traumi da forza gravitazionale.
Dopo varie prove s’imparava a regolare la pressione sul foglio: pochissima con il pennino appena estratto dal calamaio, in crescendo fin oltre metà della carica e un po’ di più quando stava per effondere la sua ultima linfa nera. L’inchiostro scendeva lungo il taglio e la pressione regolava la distanza fra le due parti e di conseguenza la quantità. C’era un pennino sfizioso a forma di pugno chiuso di mano destra con l’indice puntato in fuori. Era bello, ma di difficile uso, perché quasi tutto l’inchiostro era trattenuto nella parte del pugno e, lungo il dito in posizione asimmetrica, ne scendeva poco; anche se la carica durava di più, c’era comunque il rischio che sgocciolasse nel servirsene, non potendo appoggiarlo bene sul bordo del calamaio per togliere il liquido superfluo e si rischiava la macchia. Ogni macchia comportava automaticamente una penalità: da noi corrispondeva ad un errore grave di accento saltato sul verbo essere o su parole tronche come lunedì, città, caffè…
Questo strumento scrittorio, se tenuto in verticale, rischiava di “impiantarsi” sulla carta inceppando la corsa della mano (un impedimento deleterio soprattutto nel dettato) e poteva causare piccoli schizzi fra una lettera e l’altra, con inestetismi penalizzanti il voto di bella scrittura. La buona tecnica consisteva nell’appoggiare sul foglio il dito medio, l’anulare ed il mignolo, rigorosamente della mano destra [Vae laevis! (Guai ai mancini!) tuonavano pedagoghi alla maniera di Brenno] e di reggere con indice e pollice la penna inclinata a sfiorare la nocca dell’indice, con un angolo di torsione di pochi gradi verso lo scrivente. Entrambi gli occhi si focalizzavano nel punto di contatto del pennino con la carta, la mano procedeva relativamente veloce (non per nulla si dice scrittura corsiva) e, mentre l’altra mano reggeva sul piano inclinato del banco il quaderno, si realizzava l’ergonomia posturale del piccolo discente.
Il pennino, dopo una settimana o poco più, si “abituava” al suo padroncino, cioè prendeva la giusta piega soprattutto dalla parte a destra del taglio e rispondeva bene alla pressione, flettendosi il giusto, come un utensile personalizzato di officina meccanica moderna e quando veniva usato da altro alunno, questi avvertiva la differenza di prestazione. I pennini erano ovviamente oggetto di scambio, prestito e piccole collezioni. Già prima che il mio paese divenisse Settimo Torinese, una città in punta di penna (titolo del libro di SILVIO BERTOTTO, 1991, ediz. Amici della Musica – Iniziative Culturali) molte botteghe artigiane costruivano o montavano penne stilografiche, poi rimpiazzate da quelle a sfera ed infine dai pennarelli. Era inevitabile che qualche ragazzino venisse in possesso di pennini destinati a questi prodotti ed avvenne regolarmente anche nella mia classe, in quarta elementare. Un compagno esibì un pennino di tal genere, vantando fosse addirittura d’oro (in realtà, soltanto placcato oro): certo era di pregio, perché sull’estremità aveva la protuberanza in iridio destinata ad una gamma superiore. Ma questo lo appresi molti anni più tardi, interessandomi all’estinzione dei dinosauri causata dall’impatto con la Terra di un asteroide ricco di tale metallo abbastanza raro e resistente, usato in lega con il platino nei campioni di misura conservati presso il Bureau International di Sévres in Francia.
Nonne e zie si ingegnavano a produrre pratici nettapenne di panno, perché dopo l’uso non si depositassero residui secchi sul pennino e non pochi compagni si procurarono col tempo boccette d’inchiostro più pregiato di quello fornito dalla scuola pubblica. Ne ricordo l’odore più pungente ed il colore blu tendente al violetto prima che si asciugasse del tutto, quando non ci fosse bisogno di voltare la pagina ed intervenire con la carta assorbente. Questo accessorio si accompagnava immacolato ad ogni quaderno nuovo e moriva imbrattato di parole, numeri e macchie quando il quaderno andava cambiato. Il figlio del dottore esibiva un tampone assorbente a dondolo, decisamente ingombrante sul piccolo ripiano orizzontale del banco, ma noblesse oblige o forse semplicemente lo aveva bottinato nello studio del papà.
Sul finire della classe quinta, la maestra ci autorizzò all’uso della penna stilografica, purché economica e ci indirizzò ad un negozio che aveva stipulato una convenzione con la scuola per venderci modelli decisamente popolari: avevamo un buono di riconoscimento e con pochi soldi compravamo una penna nera, senza fronzoli e con il caricatore interno a stantuffo. S’immergeva la penna nella boccetta e si tirava su aspirando l’inchiostro, ma il gommino dello stantuffo non era a perfetta tenuta e spesso il liquido scendeva più copioso del necessario sotto la pressione atmosferica. Una siringa monouso di oggi è molto più funzionale e sicura! Ne ebbi una brutta esperienza il giorno dell’esame di ammissione alle scuole medie, dopo quello di licenza elementare. Ricordo che avevo riposto la penna caricata appositamente quel mattino presto nel taschino della giacca, fissata con la clip metallica del cappuccio. Ci fecero sedere in banchi distanziati in un corridoio e, mentre la commissione d’esame faceva l’appello dei candidati, mi accorsi con terrore che l’inchiostro era fuoriuscito tutto, imbrattandomi i vestiti e le mani. Una professoressa mi accompagnò in bagno, mi diede un rotolo di carta igienica per asciugare alla bell’e meglio l’abito ed imbottire il taschino. Mi accorsi subito della differenza fra scuola elementare e media, perché la maestra mi avrebbe aiutato, invece quella prof. mi dava secche istruzioni, ma non mi toccò nemmeno con un dito. Le mie dita invece erano tutte blu e, riaccompagnato al banco, mi furono dati un calamaio e una penna di chissà chi per svolgere la prova di italiano. Me la cavai ugualmente, benché la mia principale preoccupazione fosse rivolta alla reazione di mia madre al ritorno a casa. Eh, questo era cruccio di un undicenne! La giacca fu portata da un tintore e da grigia divenne blu scuro, per rimediare alla gigantesca macchia sul petto.
Le scuole medie non le frequentai in quella sede, ma altrove dove ci era consentito di scrivere con la “biro”; successivamente ho avuto qualche altra penna stilografica meno infida della mia prima e così con pennini e calamai non ebbi più a che fare fino a quando dovetti firmare la ricevuta del primo stipendio. Nella prestigiosa sede della Banca d’Italia di Torino, tutta marmi e vetri colorati stile cattedrale, mi fu ingiunto di servirmi di un calamaio in cui era tuffata una penna passata da innumerevoli mani che schiccherava una brodaglia nera da un pennino maltrattato da chissà quanti! Non insistetti nel protestare: di là dal vetro il cassiere stringeva i miei pochi e sudati soldi e la fila era lunga. Erano i primi anni ‘70 e forse lo Stato doveva ancora smaltire le scorte d’inchiostro di qualche decennio prima e rifiutate ormai dalle scuole.
Queste sono le caratteristiche che dovrebbe avere una funzionale penna stilografica, secondo i miei gusti e le mie esigenze: non avere orpelli decorativi luccicanti che tendono a disturbare la vista con l’illuminazione artificiale, avere una impugnatura grande ed essere relativamente pesante. Non occorre così premere sul foglio, provvede il suo intrinseco peso e la mano deve solo trascinarla con l’inclinazione di cui sopra. Ne ho una che possiede tutte queste qualità e la adibivo a redigere verbali e documenti scolastici con inchiostro rigorosamente nero. Al sopraggiungere delle vacanze, provvedevo a lavarle “le interiora” con acqua demineralizzata (quella per il ferro da stiro) ed a caricare con questa il serbatoio a mezzo siringa, affinché fosse pronta a settembre/ottobre senza depositi. Un’estate particolarmente calda, anche l’acqua si seccò e quando inserii la cartuccia nuova dovetti attendere un po’ prima che il liquido riempisse il canaletto a serpentina di sicurezza che conduce al pennino. Ora sono in pensione, ma già prima da quando le relazioni burocratiche si son fatte al computer, questa penna riposa in verticale nel barattolo sulla scrivania, rassegnata ad essere surclassata nella preferenza da altri strumenti scrittori quali rare penne a sfera, pennarelli a micropunta e la fidata matita a scatto.
Per inseguire i pensieri vaganti mi serve avere fra le mani qualcosa di rapido, appunto la matita, poi con la biro faccio le correzioni, le sostituzioni di sinonimi e solo successivamente, anche giorni dopo, trascrivo il tutto al computer. Concordo pienamente con gli esperti che lamentano lo scarso uso del corsivo nelle scuole per invadenza delle tastiere a scapito di maggior concentrazione e miglior forma.
Si dice che un celebre autore di romanzi polizieschi iniziasse la giornata col fare la punta ad un intero mazzo di matite con il temperino meccanico a manovella e si prendesse una pausa sorseggiando un bicchierino di cognac solo dopo aver aver consumato la punta di tutti i lapis ed averli travasati in altro contenitore in attesa di essere affilati nuovamente. Forse ai suoi tempi il modello da me adottato non c’era ancora o magari semplicemente non gli piaceva.
E per finire, dandomi un po’ le arie da letterato, mi va di ricordare il povero Renzo manzoniano che, seduto tavola con il gendarme sotto copertura (come s’usa dire oggi) seppur ormai brillo, rifiuta di dichiarare le generalità all’oste che, dovendo essere ossequioso alla legge, gli si è appunto messo davanti con carta, penna e calamaio. Anzi il malcapitato poi va retoricamente domandandosi a voce alta perché mai chi comanda abbia sempre a sventolare la penna. Bellissima e spiritosa la risposta d’un altro avventore che spiega: «[…] quei signori son loro che mangian l’oche e si trovan lì tante penne, tante penne, che qualcosa bisogna che ne facciano». (Cap. XIV)
Sull’onda dei ricordi miei e condivisibili da tanti altri, ho voluto scrivere su quanto s’usa e s’è usato nei secoli per scrivere, ma non posso non accennare ad un altro fondamentale strumento e lo faccio citando un vero maestro in questo campo.
Giovanni Arpino su Il racconto. Mensile d’autore, luglio 1975, pubblicato da ND, letteralmente consiglia:
«Il segreto di ben scrivere, come sostengo da tempo, è uno solo: riscrivere. Lo strumento scrittorio più necessario, non mi stanco di ripeterlo, è il cestino della carta straccia».
Prometto che non ne farò oggetto di trattazione; mi limito a dire che un tempo grandi autori (mi vengono in mente Manzoni e Collodi) lo chiamavano corbello, un termine antiquato ormai che ha una attinenza nell’altrettanto desueta parola corbelleria, dal significato di sciocchezza, roba di poco valore.