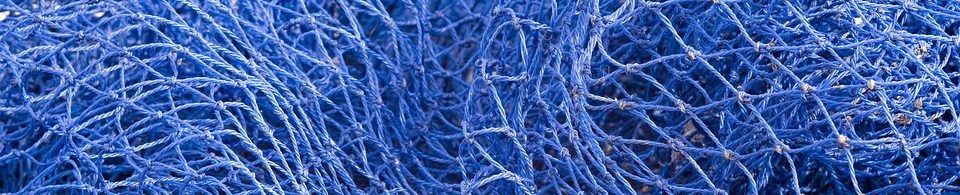“PARLI COME BADI, SA!” di Pietro Paolo Capriolo (P. P. Roe)
Sono parole del principe della risata che nel film Che fine ha fatto Totò Baby? del 1964 si mostra gravemente offeso per essere stato chiamato prosseneta. Nessuno di voi forse saprà che cosa mai significhi questo termine desueto e Totò, dopo aver ammonito l’interlocutore con la frase da me presa per titolo, pretende di essere definito piuttosto “pappa” o meglio “pappone”, cioè sfruttatore di prostitute, perché egli fa proprio questo non-mestiere, addirittura… per vocazione. Io invece baderò a non scivolare nella scurrilità.
Sono cresciuto in una famiglia che non definirei puritana, ma di puri di cuore, dove non aleggiava il suono della parolaccia né quello della bestemmia e, per imprinting culturale più che per merito soltanto personale, me ne sono anch’io astenuto pressoché sempre.
Così, non tanto per maliziosa curiosità, quanto per deontologia di studente di filologia, sono stato costretto a consultare il vocabolario in merito a termini ed espressioni che avvertivo volgari o dal doppio senso, per una necessità di disambiguazione, da quando un compagno mi fece notare che “figlio di buona donna” ha un significato completamente diverso da come suona, mentre quando Gioachino Belli dice che il papa-re ha avuto un «dolore puttano a un dente» vuole significare con questa coloritura una lancinante sofferenza fisica.
Immaginate dunque il mio stupore nell’assistere in aula universitaria ad una particolare lezione da parte del prof. Giuliano Gasca Queirazza (affabilissimo, ma altresì intransigente all’esame) che quell’anno oltre che essere titolare della cattedra di Filologia Romanza era anche incaricato di tenere il corso di Storia della Lingua Italiana. Il dotto gesuita quel giorno aveva scelto per tema il prototipo dei fumetti in lingua volgare (nel senso di non più latina) che però nel suo contenuto comprende un epiteto ingiurioso diretto alle madri dei carnefici di san Clemente e che si trova nell’omonima basilica in Roma.
Questo papa, terzo successore di Pietro e sostituito poi da Evaristo, sarebbe anche stato il primo a fare il dantesco «gran rifiuto», sebbene non per diretta volontà, ma perché esiliato da Traiano nella lontana Crimea.
Nell’affresco compaiono il funzionario Sisinnio, tre suoi sgherri ed il santo, il quale è anche l’unico a parlare ancora in latino, un latino dell’undicesimo secolo d. C. però, per di più con due errori grammaticali (l’accusativo al posto dell’ablativo causale ed un genitivo vestris con esse finale di troppo) commessi dall’anonimo artista.
Il santo, sorpreso in flagrante preghiera interdetta dall’imperatore, doveva essere condotto al patibolo, ma le funi miracolosamente e senza che i malvagi se ne avvedessero erano state legate ad una colonna giacente sul pavimento che, nonostante gli aizzamenti di Sisinnio («Fili de le pute, traite»), non voleva saperne di spostarsi. Secondo la leggenda, Sisinnio si sarebbe convertito e Clemente avrebbe fatto proseliti anche nei pressi dell’odierna Sebastopoli, cosicché Traiano ordinò che fosse gettato in mare con un’ancora legata al collo. Il mare stesso avrebbe provveduto ad accumulare pietre sul suo cadavere ed ogni anno si sarebbe ritirato per permettere ai fedeli di venire in venerazione al suo tumulo, finché i resti mortali non furono traslati in Laterano.
Descrivo brevemente l’affresco: Gosmario incita («trai» = tira) Albertello il quale consiglia l’uso della leva ad un terzo individuo che non proferisce parola («Falite deretro co lo palo Carvoncelle» = mettiti dietro con il palo, C.); il prefetto Sisinnio invece inveisce contro i suoi subalterni indistintamente, definendoli tutti non genericamente figli di puttana, bensì conferendo loro più madri meretrici («de le pute») come s’addice ad improbabili fratelli illegittimi!
Il professore non avrà certo tralasciato di far notare, pur nella grafia ancora separata, già la presenza di due preposizioni articolate inesistenti nel latino (co lo palo e de le pute) che diventeranno col e delle nella nostra lingua.
Anni dopo, una domenica pomeriggio, con un commilitone della IV Compagnia Mortai da 120 (sarcasticamente detta degli intellettuali) di stanza a Roma, ebbi modo di visitare San Clemente, la basilica superiore e quella inferiore sorta su un tempietto pagano dedicato a Mitra, e di vedere da vicino questo primitivo stile fumettistico contenente la prima parolaccia italiana in assoluto. In quel contesto, proprio non poteva mancare, anzi è un elemento caratterizzante la scena. D’altra parte, l’universale presenza di epiteti volgari è comune a tutte le civiltà.
Come mi confermò Victoria, la giovane badante peruviana di mia madre, le parolacce sono tra le prime locuzioni apprese in una lingua straniera, un po’ per l’uso offensivo nei confronti degli immigrati spesso clandestini, ma credo anche per la comune valenza nei diversi idiomi e, non da ultimo, per la vis comica caricaturale che a volte le ammanta.
Qualcuna è addirittura legata a personaggi celebri che se ne servirono in contesti storici divenuti leggendari. Tale è l’esclamazione molto in voga presso i francesi «Merde!»che può vantare il presunto patrocinio del generale Cambronne nel respingere l’invito degli Inglesi alla resa a Waterloo. Il suo manipolo rappresentava l’ultimo bastione di combattenti, asserragliato in quadrato e assalito da tutti i lati, estremo ostacolo alla dichiarazione di sconfitta di Napoleone. Di fronte a tanto valore nel resistere ad oltranza, i nemici invitano i francesi a desistere, ma Cambronne avrebbe risposto: «Merde! La Guardia muore, non si arrende», decretando così lo sterminio dei suoi soldati. Egli stesso cadde ferito alla testa, ma non morì e pare che abbia sempre sconfessato questa risposta citata perfino nell’elogio funebre alla Camera dei Rappresentanti, quando fu creduto morto. Riabilitato dai trascorsi napoleonici da Luigi XVIII, sposò una donna inglese, riuscì ad avere un titolo nobiliare borbonico e quella reazione non gli appariva per nulla cavalleresca. Avrebbe negato addirittura l’intera frase. Se ne parlò a lungo e fu Victor Hugo a risolvere la querelle con i figli di un altro generale, Claude-Étienne Michel, lui sì deceduto sul campo, che ne rivendicavano l’originalità per il loro padre. Hugo si servì della testimonianza di Antoine Deleau, fregiato della Legion d’Onore, che però non sarebbe appartenuto al battaglione di Cambronne e tuttavia, per aver sentito per oltre quarant’anni quella versione, la confermò come vera. Nonostante le sue smentite, a Cambronne nella natia Nantes venne eretto un monumento che alla base riporta la celebre frase (con tanto di parolaccia secondo voci riportate da Internet, tuttavia sempre in Internet si può vedere la statua in oggetto con la targa emendata dalla parolaccia però). Un uso più recente e direi diplomatico di questa attribuzione è venuto dal presidente Sandro Pertini che, rievocando i suoi giorni di prigionia, riferì come venivano chiamati dai compagni di lotta antifascista i delatori: con la parola di Cambronne.
Tornando all’ambito familiare, una nipotina al primo anno di asilo, lei che aveva dimestichezza al massimo con la parola sederino, un giorno sbottò con un enigmatico «Farùlo!». Alla richiesta di cosa intendesse dire, rispose con candore: «Non lo so. Quando Alberto si arrabbia, dice così». Non sto a tradurre l’espressione mal appresa dal piccolo amico che proveniva da altro contesto culturale; l’avrete capito, soprattutto in questi tempi di sdoganato turpiloquio televisivo e non. Addirittura un movimento politico ha organizzato pubbliche manifestazioni all’insegna di “Vàffa!” (Si scriverà così?).
Senza calarci nelle consuetudini dei batteri che costituiscono il microbioma intestinale (detto anche il nostro secondo cervello, secondo recenti studi) o nella mentalità di uno scarabeo stercorario che di rifiuti organici si ciba, ci possiamo tuttavia chiedere quand’è che la parola che definisce l’escremento (ma possiamo estendere il quesito anche a certe parti anatomiche) diventa parolaccia? Ritengo quando, come il Covid fece un salto di specie parassitata (spillover), la parola esce dal suo stretto contesto significativo riferito alla cosa in sé e viene esteso ad una persona (i delatori di cui sopra) o ad una situazione incresciosa (trovarsi nella emme). Di fatti portiamo con disinvoltura i campioni di urina e delle feci al laboratorio analisi.
Si narra che un medico d’altro stampo e fin troppo educato nel parlare avesse chiesto ad una anziana paziente di descrivergli l’aspetto del cilindro fecale, non ottenendo risposta se non dopo aver tradotto l’eufemismo con una comune volgarità. A Napoli, ammiccando all’indole di qualcuno, si dice che puoi insistere a metterci su del rum, ma ‘nu strunzo rimane sempre tale e non diventerà mai un babà!
E per finire due piccoli “panegirici” ai rifiuti organici equini.
Da bambino, su esempio ed incarico degli avi, spesso ho raccolto con paletta metallica e secchio gli escrementi (in piemontese: buse) lasciati per la strada provinciale al passaggio di carri trainati da sempre più radi cavalli a quattro zampe, prima che venissero spiaccicati al suolo dai veicoli che nel motore avevano la forza di diversi cavalli vapore. Era questo un rifornimento gratuito di concime rigorosamente organico ed ecologico, a chilometri zero, anzi a domicilio, da impiegare nell’orto e nei vasi di fiori. Lo facevamo in tanti senza vergogna e la strada restava pressoché pulita, senz’altro più di ora che è frequentata da cani i cui proprietari sono incuranti di raccoglierne i rifiuti .
Un altro riferimento alle deiezioni solide equine viene dal mondo artistico. L’espressione beneaugurante “Tanta merda” è significativa dello sperato successo delle rappresentazioni, nei teatri lirici e di prosa. Alle cosiddette “Prime” e alle successive repliche, gli spettatori di rango arrivavano all’ingresso a bordo di carrozze che sostavano alcuni minuti lì davanti o si fermavano nei paraggi per la durata dello spettacolo. La misura del successo (l’Auditel di allora) era dato dalla quantità di letame accumulato ogni sera. Un criterio che fa storcere un po’ il naso – per forza – ma incontestabile!